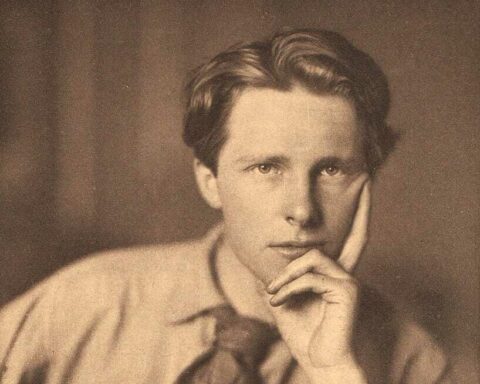Tra Ottocento e Novecento, Mary Hunter Austin è stata la scrittrice che ha raccontato i luoghi più autentici degli Stati Uniti, attraverso le vite di individui in profonda armonia con la natura, nella «terra delle piogge rare».
Nata nel 1868 in Illinois, Austin scopre il deserto negli anni successivi al college, quando si trasferisce in California con la madre: un incontro folgorante, che accende in lei la scintilla per la scrittura e la porta a diventare una delle autrici più prolifiche della sua epoca – pubblica infatti trentaquattro volumi, oltre a numerosi articoli per diverse riviste. In queste terre selvagge, Austin si dedica a lunghe passeggiate, durante le quali impara ad ascoltare il ritmo della vita del luogo, incontra abitanti e avventurieri, e ascolta le loro storie.
Nel 1891 sposa l’insegnante Wallace Austin, e la coppia si stabilisce tra Bakersfield e la Owens Valley, terre semidesertiche che diventeranno lo sfondo privilegiato della sua produzione letteraria. Quando il marito perde il lavoro, la coppia è costretta a lasciare la casa e Austin si ritrova a vivere temporaneamente in una pensione che ospita minatori affetti da saturnismo. È in questo ambiente, segnato dalla fatica e dalla malattia, che la scrittrice entra in contatto con storie di vita reale, dure ma autentiche, che ascolta con attenzione e trasforma in materia narrativa. Quelle voci, spesso escluse dai resoconti ufficiali, trovano spazio nella sua scrittura, contribuendo a costruire un’idea di letteratura profondamente radicata nella realtà materiale e capace di restituire dignità a chi abita le periferie geografiche e sociali del Paese. Il “racconto dentro il racconto” è una formula ricorrente nei testi di questa antologia: molte storie sono narrate in terza persona o riportate direttamente da un personaggio, in una forma che conferisce loro un’aura di leggenda che ben si inserisce nel contesto narrato. “La terra”, ad esempio, è un racconto costellato di storie di questo tipo, che costruiscono un immaginario alternativo – ma geograficamente analogo – che si sovrappone al racconto principale, generando rimandi ai vissuti annotati da Austin nel corso degli anni.
Nel 1892 nasce la sua prima figlia, Ruth: con lei Austin riprende le sue passeggiate per esplorare l’ambiente circostante e inizia a frequentare un accampamento di nativi americani, dove approfondisce la conoscenza delle storie e delle usanze dei Paiute. Saranno proprio i Paiute a prendersi cura di Ruth quando, ancora molto piccola, le viene diagnosticata una disabilità intellettiva, mentre il padre si allontana progressivamente dalla famiglia.
Nei racconti di Austin, i nativi non sono mai rappresentati in modo stereotipato, ma osservati con rispetto e descritti con precisione, proprio come i luoghi in cui vivono. La cautela e l’equilibrio sono tratti distintivi della prosa della scrittrice, che rifugge ogni osservazione fredda e distaccata, preferendo uno sguardo imparziale e rispettoso. Allontanandosi dalla visione dominante dell’epoca, Austin restituisce ai nativi e alle loro tradizioni una dignità narrativa, resa possibile anche dal legame diretto e profondo che ha saputo instaurare con questo popolo.

Nei primi anni del Novecento, dopo essersi unita a una comunità di artisti, la scrittrice ha l’occasione di viaggiare in Europa e di trascorrere un periodo a New York, dove conosce numerosi intellettuali e figure di spicco dell’epoca, tra cui Henry James e Charlotte Perkins Gilman, e sviluppa un crescente interesse per le cause femministe e i movimenti per i diritti dei lavoratori. Negli anni successivi, anche grazie a un nuovo incarico come insegnante, Austin si trasferisce con la figlia in California, fino alla tragica morte della bambina nel 1918. La sua prematura scomparsa lascia un segno profondo nella vita e negli scritti dell’autrice: nel racconto “La Donna in Cammino”, la protagonista diventa portavoce di una tenerezza materna e di un amore profondo per un figlio perduto. La scrittrice vive i suoi ultimi anni – già divorziata dal 1914 – in completa solitudine, fino alla morte nel 1934.
La produzione di Mary Hunter Austin è fortemente influenzata dal suo vissuto – dagli incontri con i nativi e dalla sua storia personale, ma soprattutto da quelle terre che ha abitato e tanto amato. Il deserto che prende forma dalle sue parole è un luogo incontaminato, in cui vige una legge autonoma e indipendente dalle leggi umane. È un ambiente dove la natura si esprime secondo ritmi e logiche indipendenti, affascinanti proprio perché impossibili da imbrigliare – come un’antilope, libera e sfuggente. È un deserto che non si lascia descrivere in maniera romantica e idealizzata, ma che Austin riesce a cogliere – proprio perché l’ha vissuto in prima persona – anche nei suoi lati più duri: è una terra difficile, che cela però in questa difficoltà una particolare bellezza che Austin rivendica fieramente. Il suo attivismo non si concretizza quindi solo nell’atto pratico – la denuncia dello sfruttamento di queste terre così preziose –, ma anche e soprattutto nel dare luce, attraverso la sua scrittura, a una terra e a dei popoli troppo spesso dimenticati. Questa attenzione ecologica ante litteram si intreccia perfettamente con gli ideali femministi che Austin porta avanti: il deserto, sempre nel racconto “La terra”, prende le sembianze di una donna e come lei diventa fiero, affascinante e indomabile, si fa rispettare e non si fa ingabbiare da nessuno.
Gli ideali femministi di Austin si riflettono anche nei suoi racconti successivi, come il sopracitato “La Donna in Cammino”, il ritratto di una donna libera dalle convenzioni sociali, che sceglie per sé, ama e vive come desidera. Anche Catameneda, la moglie del narratore di “Agua Dulce”, pur rimanendo nel ruolo convenzionale di sposa e nonostante non parli la stessa lingua del marito, riesce ad affermarsi come una donna sicura, capace di prendere in mano la situazione quando l’uomo cede. In “Agua Dulce” e in altri racconti di questo volume, i ruoli di potere si invertono: è Catameneda ad assumere una posizione di controllo nella coppia, così come la Natura desertica impone il proprio dominio sui personaggi maschili. La sfera femminile si emancipa dalle convenzioni sociali e si afferma come forza attiva e determinante nella narrazione. Questa rivendicazione del femminile emerge con particolare forza nel primo racconto di questa antologia, “Donna sola”: un testo autobiografico, ma soprattutto un testamento ideologico dei valori di Austin, profondamente radicati nella sua esperienza personale e restituiti con la lucidità e la precisione che definiscono la sua scrittura.
Bibliografia
E.F. Lanigan, Mary Austin: Song of a Maverick, The University of Arizona Press, Tucson, 1997.
S. Goodman, C. Dawson, Mary Austin and the American West, University of California Press, Berkeley, 2008.
M. Graulich, E. Kilasmith, Exploring Lost Borders: Critical Essays on Mary Austin, University of Nevada Press, Reno, 1999.
H. Schaefer, Mary Austin’s Regionalism. Reflections on Gender, Genre, and Geography, University of Virginia Press, Charlottesville, 2004.
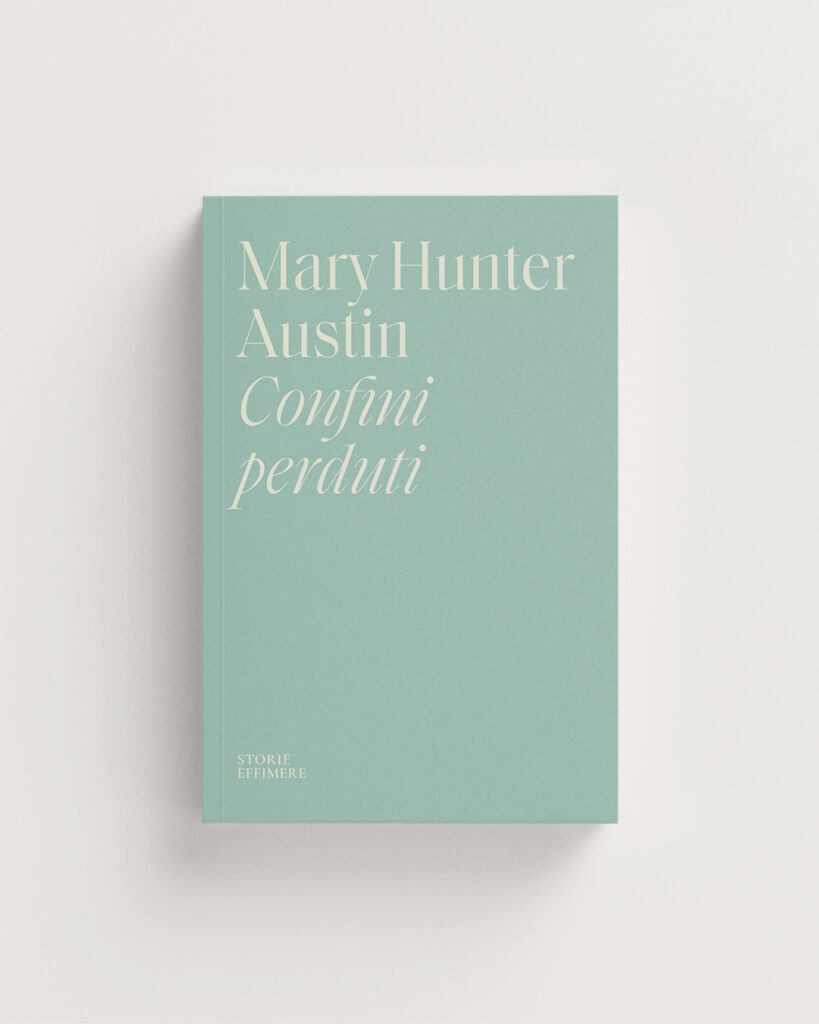
Confini perduti
Mary Hunter Austin
Nei racconti di Confini perduti, Mary Hunter Austin trasforma il deserto nella culla di storie intense e suggestive. Con la sua scrittura evocativa, ci guida oltre i confini tracciati, verso le zone degli Stati Uniti più selvagge e autentiche.